La mappa dei vinti: Capitolo 3 (un romanzo by @kork75)
Nel marzo del 1952, Enea De Lorenzi fa ritorno a Livorno dopo anni di lontananza, richiamato per essere reintegrato nella Marina Militare. Il suo rientro riapre ferite antiche, ma segna anche l’inizio di un percorso di rinascita personale, mentre si confronta con ricordi dolorosi e valutazioni severe. Una telefonata urgente lo coinvolge nella drammatica vicenda di Alena Pavelic, una figura a lui legata, ora in pericolo a Trieste. Determinato a proteggerla, Enea si prepara a trasferirsi a Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, dove spera di trovare non solo un nuovo incarico, ma anche l’opportunità di ricostruire sé stesso e raggiungere finalmente una pace interiore.

Microsoft Copilot - prompt by @kork75
Il viaggio era cominciato a Trieste due giorni prima, con cambi lenti e stazioni affollate. Ora, dopo l'ultima tratta da Firenze, il treno si era fermato da cinque minuti sotto il cielo lattiginoso della stazione centrale di Livorno. Enea De Lorenzi fu l'ultimo a scendere, con una sacca a tracolla e una vecchia valigia. Il suo passo era lento, pesante, quello di chi non ha più nulla da dimostrare. Indossava ancora il gessato scuro preso da un rigattiere del porto, un po' largo sulle spalle, con le cuciture imprecise. Il tessuto, già logoro, aveva preso pieghe definitive nel lungo viaggio. Le scarpe, le stesse semi-usate comprate con le ultime lire, cigolavano a ogni passo, come a ricordare che anche i piedi, prima o poi, invecchiano.
Enea si fermò all'imbocco del sottopassaggio. L'odore di nafta e ferro gli risalì in gola, identico a quello dei sommergibili: metallo, umidità, vite sospese tra pressione e silenzio. Inspirò a fondo, ma una fitta alla spalla sinistra gli mozzò il respiro. Era un dolore antico, il ricordo tagliente di una notte d'inverno del '43, quando la carlinga del Persico era ceduta sotto la deflagrazione di un siluro. Da allora, il suo braccio non era più stato lo stesso e ancora tremava appena.
Non aveva quasi nulla con sé. Tutto era rimasto nella sua stanza a Trieste: un letto sfondato, una stufa inutilizzabile, un armadio impregnato di muffa e odore di carbone. Portava soltanto una valigia di cartone rinforzato, dentro la quale aveva riposto il suo vecchio berretto della Marina, qualche indumento e un fascicolo con il timbro del Ministero della Difesa: un ordine di richiamo che non prometteva alcuna certezza. Lo aspettava soltanto un’altra verifica. Un altro giudizio.
All'uscita della stazione, un vento salmastro e secco gli portò in faccia sabbia fine e promesse sfilacciate. I taxi erano pochi, solo due, e le facce dei tassisti erano ruvide e indifferenti.
Uno di loro lo adocchiò: “Accademia Navale?”Enea annuì.
Non si scambiarono altre parole durante il tragitto. Enea osservava la città: viali spogli, palazzi bassi, la calma forzata di Livorno, le ville liberty dell’Ardenza, il lungomare, e infine il viale dell’Accademia. Trieste era troppo distante ormai, meglio così pensò: una città che viveva trattenendo il fiato, sempre sull’orlo di una frattura.
Trieste già. Gli tornò in mente Alena: la vestaglia troppo grande, lo sguardo velato di gin e rimpianto, e quel silenzio che riempiva le stanze più delle parole. Non si erano detti addio. Lei aveva scelto di andarsene con uno sconosciuto e un mazzo di camelie bianche tra le dita, lasciando dietro una porta sfondata e un letto disfatto. Enea non aveva provato a fermarla. In quella casa, i sentimenti erano stati assenti quanto il riscaldamento.
E poi il ricordo amaro di Bogo. Il cane spelacchiato e randagio, trovato tra le rotaie umide del magazzino 23, con una ferita sul dorso e una corda al collo. Lo aveva chiamato così senza pensarci troppo: bogo, come si dice a Trieste di chi è lento, un po’ tonto, sgraziato ma simpatico. Forse perché, a modo suo, quel cane gli somigliava. Era stato l’unico a seguirlo davvero, persino per sei piani di scale.
Ma era durato poco. Troppo freddo. Troppa fame. Troppa solitudine, anche per un cane. Si era spento tra le sue braccia, in silenzio, mentre la città, fuori, non portava che nebbia.
L’Accademia apparve tra i pini marittimi come un vascello bianco arenato sulla costa. L’autista lo lasciò davanti al cancello. Mostrò i documenti, firmò il registro, poi entrò. L’androne era immenso, silenzioso, odorava di cera e naftalina. Tutto sembrava rimasto congelato al 1939. Le stesse scale, gli stessi ritratti di ammiragli, le stesse ombre sulle pareti. Solo gli uomini erano cambiati. Lo condussero in una stanza del terzo piano: spoglia, con un letto da campo, un armadietto e una scrivania di legno graffiato. Nessun alloggio decoroso era previsto per lui. “Periodo di valutazione”, gli dissero. Enea non chiese nulla. Si spogliò lentamente, piegò il gessato con cura e si sedette sul letto. Dalla finestra, il mare era una striscia grigia e immobile all’orizzonte. Sfilò dalla sacca un oggetto avvolto in una stoffa scura. Lo srotolò con attenzione. Una vecchia foto in bianco e nero, sbiadita dal tempo: lui, vent’anni prima, in divisa da marinaio con accanto a un giovane eritreo. Sul retro, una scritta tracciata a penna: Massawa, 1938. Il ragazzo sorrideva pieno di futuro. Lui no.
Si sdraiò sul letto senza togliersi le scarpe. Stringeva la fotografia come si stringe ciò che non si vuole più perdere. Lo attendeva un lungo percorso, indossando una nuova divisa da ufficiale: colloqui con psicologi, test fisici, interrogazioni tecniche. Avrebbero scavato tra le macerie del suo passato, cercando qualcosa da recuperare, da rimettere in servizio. Non sapevano,o forse sì, che il vero naufragio era iniziato dopo la guerra, quando nessuno aveva più bisogno di sommergibilisti, ma solo di impiegati silenziosi e uomini obbedienti.
Nei mesi successivi, la sua vita all’Accademia avrebbe assunto il ritmo severo delle giornate regolamentari: sveglia all’alba, ispezioni minuziose, turni di guardia, documentazioni da compilare con ossessiva precisione, corsi, conferenze, esami. Ogni settimana una nuova valutazione. Ogni giorno, lo stesso interrogativo muto negli occhi dei superiori: Vale ancora qualcosa, quest’uomo?.
Ma Enea accettava quel percorso. Non per convinzione. Non per fede. Ma perché era l’unica direzione rimasta. E tra le mura rigide dell’Accademia, nel rumore secco dei passi sui pavimenti di marmo, cominciava lentamente a riemergere. Non era un ritorno. Non ancora. Era solo un’altra tregua. Ma forse, quella volta, sarebbe bastata. I mesi trascorsero e il comandante De Lorenzi fu reintegrato in servizio attivo, assegnato al corpo delle Capitanerie di Porto. Non restava che attendere, nelle assolate giornate di maggio, l’ordine di trasferimento.
.jpg)
Microsoft Copilot - prompt by @kork75
La telefonata arrivò in mattinata, durante la conferenza di Diritto della Navigazione. Il sole filtrava dalle finestre, riflettendosi sulle divise impeccabili. L’aria era densa di silenzio e disciplina. Un colpo secco bussò alla porta.
"Comandante De Lorenzi?" chiese il giovane allievo.
Enea sollevò lo sguardo dal codice.
"C’è una comunicazione urgente per lei. Una telefonata personale."
Uscì con passo rigido, lo stomaco contratto. Il corridoio era un tunnel dove ogni rumore moriva. In segreteria lo attendeva un telefono grigio, posato come un relitto sulla scrivania. Un sottufficiale gli porse la cornetta.
"È per lei, comandante." Poi si allontanò, lasciandolo solo.
Enea la prese con mano incerta.
"Pronto? De Lorenzi."
La voce dall’altra parte era ferma, con un accento del nord:
"Buongiorno. Sono il commissario Troncon, della Questura civica di Trieste. Operiamo sotto il coordinamento del Governo Militare Alleato. Lei conosce una certa Alena Pavelic?"
Il cuore di Enea mancò un battito.
"Sì. Perché? Cos’è successo?"
Silenzio. Un respiro trattenuto. Poi il commissario parlò, misurando le parole:
"L’abbiamo trovata venerdì scorso notte, chiusa a chiave in un ripostiglio dentro un capannone industriale alla periferia est. Sul posto, segni di sparatoria. Due cadaveri: un uomo italiano e una donna slava."
"Mio Dio… Ma Alena? Che ci faceva lì?"
"Secondo quanto ricostruito, è stata attirata con una scusa, un’offerta di lavoro, una trappola. Sospettiamo fosse una riconsegna clandestina oltre il confine jugoslavo. Non sarebbe la prima volta. Inoltre, il cognome Pavelic non è proprio ben visto dai rossi, se capisce," spiegò il funzionario di polizia.
Enea strinse la cornetta, la mano tremava ancora di più.
"Sta dicendo che volevano... rapirla?"
La mente di Enea si bloccò sul nome: Pavelic. L’orrore di quel passato aveva un volto. Era il nome di un genocidio, l’eco di una pulizia etnica. Ante Pavelic, capo degli Ustascia, era ricercato dai partigiani di Tito in tutta l’Istria, nonché dai governi di mezza Europa. Seguì una pausa, più pesante. Enea sentì il suo respiro e poi quello del commissario.
"Forse sì. O forse peggio. Ma non lo sappiamo. Quello che le posso dire è che Alena è viva."
Enea si ritrovò ad allentare la presa sulla cornetta, un peso improvviso scivolato via.
"Grazie. Come sta?"
"Al momento della sparatoria era già prigioniera. Legata mani e piedi a una sedia e imbavagliata. Disidratata. Confusa. Dice di non aver udito spari, solo voci concitate, poi il silenzio. Quando siamo arrivati, era sconvolta. È stata rilasciata la sera stessa dagli americani."
"E i morti?" domandò Enea, la voce per un attimo aveva riacquistato il tono metallico dell'ufficiale di Marina, quello che chiedeva un rapporto danni dopo un attacco.
"Le posso dire quello che può leggere anche sulla cronaca. Un regolamento di conti, forse. Uno era un trafficante, a quanto pare. Abbiamo trovato una pistola. La donna slava non sembra avere legami né con gli Ustascia né con i Titini."
Il commissario si schiarì la gola.
"Ora le parlo in via ufficiosa. Non ci sono prove certe che colleghino il cognome al crimine e al rapimento di Alena. L’ho fatto io il collegamento, è una pista su cui sto indagando. Ma le assicuro che ci arriveranno anche gli americani. È questione di ore. E a quel punto, la Pavelic non sarà più la “sconvolta” di un regolamento di conti tra trafficanti."
"E adesso?"
Il tono del commissario si fece più basso.
"Il problema è che non ha un posto dove andare. Niente casa, niente soldi. È pur sempre un’esule slava. Due giorni fa l’abbiamo trovata alla stazione centrale. Dormiva su una panchina. Aveva fame, era infreddolita. E... ha fatto il suo nome."
Enea chiuse gli occhi. Il volto di Alena gli tornò alla mente, lo sguardo duro, di chi si è abituato a nascondere la paura. La solitudine le si era cucita addosso come un’ombra. E lui l’aveva lasciata sola, in una città che era diventata una trappola. Trieste, in quell’anno sospeso tra due mondi, era una terra di confine: troppo vicina a un limite che non perdonava, troppo lontana da ogni vera protezione.
"Capisco. Anzi no… perché vuole aiutare?" domandò Enea.
Non era il tipo da credere nella generosità disinteressata, e pensò che denunciando Alena, Troncon avrebbe potuto ottenere un guadagno di carriera facile, specialmente se la donna era realmente coinvolta nel regime degli Ustascia. Poi il commissario restò in silenzio un istante, come se valutasse se proseguire.
"De Lorenzi... ora glielo devo dire. Io ero alla stazione di Trieste nel ’46, addetto alle schedature dei rientrati dai campi. A ogni convoglio, a ogni volto stanco che scendeva dai vagoni, chiedevo sempre una cosa in più: se qualcuno avesse conosciuto Fabrizio Troncon, mio padre."
Enea tacque. Gli tornarono in mente le divise polverose, i volti smunti, i silenzi affamati.
"Lo ricordo," disse infine.
"Lei era dietro un tavolo, la penna in mano e un diario davanti. Le dissi che avevo conosciuto suo padre, che era un uomo giusto, rispettato da tutti nel campo. Ma che non ce l’aveva fatta. Era morto pochi giorni prima della liberazione. Per malattia, credo. Nessuna colpa, solo la fame e l’inverno."
La voce di Troncon si abbassò.
"Lei aveva uno sguardo fermo, pulito. Mi ha detto quelle parole senza esitare, ma con rispetto. Mi fecero male, ma anche bene. Era la verità, e me la disse guardandomi in faccia. Non l’ho dimenticato."
Un attimo di pausa. Poi aggiunse con tono quasi affettuoso:
"Quindi quando la donna ha fatto il suo nome, non ho esitato ad aiutare. E poi, a Trieste, bastava chiedere al porto: 'Conoscete De Lorenzi?' e tutti sapevano. La chiamano l’Africano, vero? Per via degli anni passati nelle colonie… ma la narrazione parlava poi di un miserabile allo sbando."
Enea sorrise appena, con amarezza.
"Tempo passato."
"Già. Infatti mi fa piacere vedere che la sua vita ha preso una direzione."
Il commissario sospirò e continuò su Alena.
"Al momento è in una cella di custodia temporanea al carcere femminile. Non è in stato d’arresto. Ma non sapevo dove altro portarla. Il dormitorio della Croce Rossa è pieno. E quando ha provato a rientrare nel suo alloggio, ha trovato la serratura cambiata. Qualcuno ha preso possesso della stanza. E lei non ha documenti per reclamarla."
Enea strinse la cornetta.
"Cristo."
"La sorvegliano due agenti donne. Non è trattata da detenuta, ma non può restare lì a lungo. Deve trovare una sistemazione, o andarsene prima che si metta in moto la macchina investigativa alleata."
Un silenzio breve. Poi la voce di Enea, roca ma ferma:
"Commissario Troncon, la Pavelic è sotto la mia responsabilità. Le manderò del denaro oggi stesso, con un vaglia postale o tramite una staffetta militare. Servirà per il treno, o per qualsiasi mezzo trovi. Ditele che deve raggiungermi in Sicilia, presso il mio comando a Favignana."
"Scelta coraggiosa, De Lorenzi. Sa cosa le dico? Forse Favignana è il posto migliore che le potesse capitare. Sono tempi complicati.”
“La questura terrà traccia della sua posizione. Come le ho detto l’indagine è anche dalla polizia americana. Ma entrambi vogliamo solo tenere Alena al sicuro. Fuori dai guai. Giusto, De Lorenzi?”
“E lo resterà.”
“Spero sappia in che situazione delicata si sta mettendo. Alcuni nomi, e questo poi, attirano attenzioni. Dovrò fare il suo nome agli angloamericani comandante.”
“La mia coscienza è a posto, commissario. Sto facendo la cosa giusta”.
Per un attimo penso a quella di Alena di coscienza, era solo un caso di anomia o c'era altro, comunque di scheletri nascosti ne aveva parecchi anche lui quindi non era quello il momento di giudicare, sentenziare o di esitare. Dall’altra parte della linea, solo il fruscio lontano della città.
Poi la voce, più umana:“La informerò io personalmente Alena. E la metterò sul primo treno utile. Resti in linea e lasci un recapito a un mio agente. Le invierò un telegramma con il punto di contatto per l’invio del denaro.”
“Grazie.”
Enea rimase immobile, il telefono in mano, molto dopo che la linea era caduta. Come se le parole appena dette avessero un peso troppo grande per svanire subito. La promozione a capitano lo avrebbe portato a Favignana, un incarico d’ufficio sull’isola più remota delle Egadi. Lontano dal mare aperto che un tempo aveva solcato con passione. Eppure, quel lembo di Sicilia immerso nel Mediterraneo sembrava ora l’unico approdo possibile. E forse, forse, era davvero un nuovo inizio. Per lui. Per lei. Per qualcosa che ancora non aveva un nome, ma che non voleva più lasciar andare: pace interiore.
Continua...
Profilo dei Personaggi
Enea De Lorenzi
Nato a Roma nel 1905, Enea De Lorenzi ha vissuto un’infanzia divisa tra Italia ed Eritrea, dove ha imparato l’amarico come prima lingua, prima di padroneggiare l’italiano. Questa radice coloniale gli ha lasciato una doppia identità, facendolo sentire uno straniero in entrambe le terre. Ufficiale della Regia Marina, si è formato all’Accademia Navale di Livorno e ha prestato servizio come sommergibilista durante la Seconda guerra mondiale. Sopravvissuto all’affondamento del sommergibile Persico nel 1943, è stato poi internato nel campo di prigionia di Sachsenhausen, dove ha subito ferite sia fisiche che psicologiche. Il ritorno in Italia nel 1946 non ha significato un ritorno alla normalità. La diagnosi di “nevrosi da guerra” lo ha escluso dal mondo lavorativo, relegandolo a una vita di solitudine e alcolismo a Trieste, una città al confine sospesa tra vecchie e nuove tensioni politiche. Nel 1952 riceve un ordine di richiamo dalla Marina per un possibile reintegro, una sfida che rappresenta una sorta di ultima opportunità per riscoprire un senso e una pace interiore. La sua storia è segnata da ferite profonde, un passato ingombrante e la lotta per ricostruire una vita in bilico tra rimpianti e speranze.
Timeline degli eventi:
1905: Nasce a Roma.
1912: Trasferimento in Eritrea con la famiglia, dove cresce imparando l’amarico.
1938: Si arruola volontario nella Regia Marina e frequenta l’Accademia Navale di Livorno.
1939: Frequenta la scuola sommergibili a Pola.
1940: Perdita del padre durante i bombardamenti inglesi su Massaua.
6 marzo 1943: Il sommergibile Persico affonda; Enea è uno dei pochi sopravvissuti con una ferita alla spalla sinistra.
1943–1945: Prigioniero nel campo di internamento di Sachsenhausen, subisce traumi fisici e psicologici gravi.
1946: Ritorno in Italia, segnato da “nevrosi da guerra”, escluso dal lavoro militare.
1946–1952: Vive a Trieste in isolamento, in condizioni precarie.
Marzo 1952: Richiamato all’Accademia Navale di Livorno per un possibile reintegro. Inizia un percorso di valutazione fisica, psicologica e professionale.
Maggio 1952: Promosso capitano e assegnato al corpo delle Capitanerie di Porto, in attesa di trasferimento a Favignana.
Maggio 1952: Riceve una telefonata urgente dalla Questura di Trieste riguardo Alena Pavelic, una donna legata al suo passato, trovata in pericolo. Decide di prenderla sotto la sua protezione e farla trasferire a Favignana.
Alena Pavelic
Alena è una donna i cui occhi raccontano storie di terre spezzate e confini instabili. Trentenne di origine slava, porta con sé il peso di una fuga da una Jugoslavia dilaniata dalle tensioni politiche e dalle purghe di Tito. La sua bellezza, un tempo viva, è ormai segnata dalla fatica e dalla paura di chi ha dovuto scegliere tra la sopravvivenza e la perdita di sé stessa. Senza famiglia né un vero rifugio, Alena è arrivata a Trieste cercando sicurezza ma trovando soltanto nuove insidie. Il suo legame con Enea è fragile e complesso, nato da una convivenza più necessaria che affettiva, due sopravvissuti legati dalla solitudine e dai fantasmi del passato.
Timeline degli eventi:
1922: Nata in una famiglia contadina slava, in un villaggio nei Balcani.
1940-1945: Cresce durante gli anni di guerra e occupazioni, vivendo l’instabilità e la paura tipiche della regione.
1945-1948: Assiste all’ascesa del regime comunista di Tito e alle repressioni contro oppositori e minoranze, periodo durante il quale inizia la sua fuga.
1949: Lascia la Jugoslavia in circostanze difficili, attraversando confini pericolosi e rischiando la vita.
1950: Arriva a Trieste, città di confine e caos, senza casa né appoggi.
1951: Incontra Enea De Lorenzi; la loro convivenza nasce dalla necessità più che dal legame affettivo.
Marzo 1952: Viene trovata in pericolo in un capannone abbandonato con segni di violenza, arrestata temporaneamente e poi liberata.
Maggio 1952: Si trasferisce a Favignana sotto la protezione di Enea, cercando una nuova possibilità di vita lontano dalle ombre del passato.
Commissario Troncon
Fabrizio Troncon è un commissario della Questura civica di Trieste, impegnato in un momento storico complesso e delicato, sotto il coordinamento del Governo Militare Alleato. Uomo di poche parole ma di forte determinazione, Troncon ha un legame personale con il passato di Enea De Lorenzi attraverso la storia di suo padre, che ha conosciuto nei campi di prigionia. La sua esperienza e la sua sensibilità lo portano a gestire con attenzione situazioni difficili come quella di Alena Pavelic, bilanciando doveri istituzionali e compassione umana. Nonostante la rigida disciplina del suo ruolo, mostra una vena di empatia e un senso di giustizia che lo spingono ad aiutare Enea e Alena in un momento cruciale.
Timeline degli eventi:
1946: Addetto alle schedature dei rientrati dai campi di prigionia a Trieste, durante questo periodo incontra Enea De Lorenzi e lo ricorda per la sua dignità e rispetto, nonostante le difficoltà.
Fine anni ’40 - inizio anni ’50: Lavora come commissario alla Questura civica di Trieste, operando sotto la supervisione del Governo Militare Alleato, in un contesto di tensioni politiche e sociali tra Italia e la Jugoslavia.
Marzo 1952: Contatta Enea De Lorenzi riguardo alla situazione critica di Alena Pavelic, dimostrando fiducia e volontà di collaborare per proteggere una persona in pericolo.
Capitoli precedenti

Greetings by @kork75👋
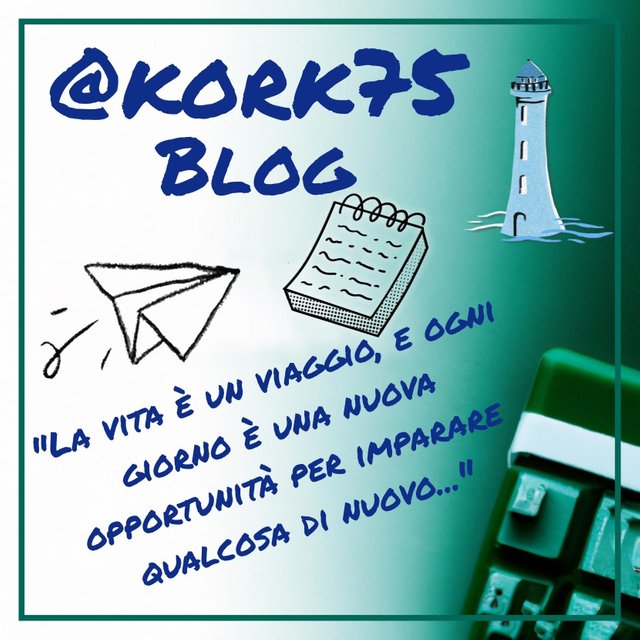
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community